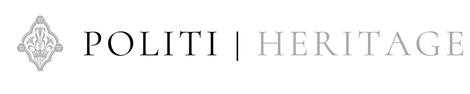|
Lo sfregio della tomba del Beato Angelico alla Minerva perpetrato in queste ore è, al di là del danno materiale, fortemente simbolico. Uno sfregio ad uno dei rappresentanti di quell'Ordine che, strutturando la dottrina della Chiesa, ha contribuito a formare il pensiero e la morale dell'Europa. Ma anche uno sfregio ad uno dei maggiori esponenti del Rinascimento, dell'italianità più vera, della rivoluzione del linguaggio artistico in termini moderni. Il Beato Angelico è stato il protagonista di un mondo dove la Bellezza, la Ragione, il Pensiero e la Religione hanno forgiato un' italianità che ha reso questo Paese il capolavoro che tutti conosciamo. Non ci stupiamo se questi sfregi avvengono in un'epoca, la nostra, dove tutto ciò viene negato.
0 Comments
C'è sempre un fatto che colpisce il viaggiatore durante i suoi percorsi. E molto spesso torna una domanda, quasi infantile, ma che nasconde in sè un certo sconcerto. Spesso a chi come noi si occupa di turismo e di cultura si chiede come sia stato possibile in passato, senza mezzi adeguati, in condizioni che oggi considereremmo disagiate, con un analfabetismo diffuso, riuscire a creare opere eccelse. Opere che noi oggi studiamo sui libri, che fanno parte di quel bagaglio culturale che una persona mediamente dovrebbe avere, e che riescono a superare i secoli. E ciò vale non solo per le opere d'arte, ma per tutte quelle attività dell'ingegno umano che hanno portato a "modellare" la natura senza violentarla, creando dei paesaggi che hanno permesso alla nostra nazione di fregiarsi del titolo di "Bel Paese".
Di contro, tutta questa meraviglia sembra perdersi in un attimo alla vista di una società che riesce a creare solo brutture, dove la richiesta culturale si abbassa vertiginosamente e dove molti sembrano essere refrattari a quanto di bello ci circonda ripiegandosi su una realtà immaginaria in cui il monumento o il paesaggio è solo il pretesto per scattarsi un selfie . Di fronte a tale scompenso, occorre quindi ripartire dal primato della bellezza come primato sociale. Per mezzo secolo le nostre città, i nostri borghi, sono stati soffocati da enormi palazzoni di cemento armato, senza identità, capaci solo di destrutturare il sistema sociale che i paesi e le città d'Italia hanno avuto per secoli. Nei quartieri periferici non vi è più quella bellezza umana, fatta di condivisione sociale ed emozionale che caratterizzava i quartieri popolari del passato. Ecco, quindi, che diventa urgente riappropriarsi della bellezza per riappropriarsi della nostra umanità. Non importa dove si vive o se si ha la possibilità di viaggiare. Ogni piccolo angolo d'Italia conserva delle specificità che lo rendono unico, custode di tesori d'arte incredibili, che non possono, a differenza dei comparti industriali, essere riprodotti in serie o delocalizzati. Su questa bellezza occorre investire seriamente lasciando da parte gli interessi dei pochi a favore della crescita sociale dei molti. Occorre che le Amministrazioni pubbliche abbiano una visione oculata e competente per garantire che ciò che si è prodotto per secoli non si distrugga per incuria o, peggio, per ignoranza. Non è più possibile lo sperpero di somme anche ingenti da parte di Enti Locali per finanziare azioni che lasciano il tempo che trovano senza poter avere una progettazione di ampio respiro che miri alla fruizione del patrimonio artistico e paesaggistico da parte di tutti. La bellezza, infatti, è anche strumento di crescita sociale, di sviluppo civico, di legalità. Non è accettabile che si parli di arte, di cultura, e di accoglienza e paradossalmente si propongano azioni premianti nei confronti dell'abusivismo e della violazione della norme. Bisogna comprendere che l'arte e la cultura hanno il compito primario di rendere uomini migliori e quindi generare un'economia equa, a misura d'uomo, che basandosi sul grande patrimonio della tradizione italiana garantisce qualità ed eleganza. E' impegno di tutti e di ciascuno educare ed educarsi alla bellezza, perchè solo attraverso essa è possibile un nuovo rinascimento che possa permettere all'Italia di essere ancora il Paese più bello del mondo. |
|
CONTATTI:
mail: info@elvinopoliti.it Tel: 380 7784553 LECCE - ROMA - MILANO - PARIGI
|


 RSS Feed
RSS Feed